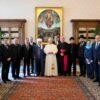K metro 0 – Bruxelles – Ci sono pochi molto più ricchi, e ci sono molti ma più poveri in questa Europa che fa fatica a diventare veramente unita. Thomas Piketty ne parla da anni, ben prima dei gilets jaunes. Il professore parigino, diventato un guru della distribuzione del reddito, focalizza l’attenzione sulle diseguaglianze ed
K metro 0 – Bruxelles – Ci sono pochi molto più ricchi, e ci sono molti ma più poveri in questa Europa che fa fatica a diventare veramente unita. Thomas Piketty ne parla da anni, ben prima dei gilets jaunes. Il professore parigino, diventato un guru della distribuzione del reddito, focalizza l’attenzione sulle diseguaglianze ed ha messo in azione una rete di centinaia di colleghi economisti, sparsi nelle università europee. È nato così il World Inequality Database che cerca di calcolare le differenze di ricchezza all’interno dei singoli stati e tra i Paesi dell’Ue.
Una rapida scorsa alle cifre mostra quanto sia ancora lontano l’obiettivo contenuto nel trattato di Lisbona: “L’Unione Europea promuove la coesione economica, sociale e territoriale tra gli stati membri”. Le differenze sono notevoli. Qualche cifra per dare un’idea: in Germania il reddito medio di un individuo adulto è di 39.420 euro, in Italia di 29.450, in Francia 35.130, in Grecia 20,670, in Croazia 19.070, in Polonia 22.510… e così diversificando.
 Roberta Carlini, giornalista di Internazionale, ha dedicato un lungo articolo molto documentato a questo tema: “Rispetto ai livelli di partenza, quelli del 1980, le differenze sono abbastanza evidenti. Ma sono visibili anche nelle dinamiche, confrontando i redditi in vari gruppi di paesi e la media europea: il blocco nordico resta ampiamente in vetta con un reddito del 50 per cento più alto di quello della media europea (mentre alla metà degli anni novanta la differenza era solo del 25 per cento); quello occidentale segue a distanza, più alto del 25 per cento; quello del sud, sceso sotto la media europea con la grande crisi del 2008, adesso è il 10 per cento in meno; mentre quello dell’est imbocca una direzione opposta, guadagnando gradualmente terreno ma restando del 35 per cento sotto la media. I paesi ex comunisti entrati nell’Ue hanno registrato, tra il 2000 e il 2017, tassi di crescita annuali medi del 2,9 per cento, mentre nel nucleo originario dell’Europa a 15 il reddito medio pro-capite cresceva, negli stessi periodi, dello 0,4 e dello 0,8 per cento”.
Roberta Carlini, giornalista di Internazionale, ha dedicato un lungo articolo molto documentato a questo tema: “Rispetto ai livelli di partenza, quelli del 1980, le differenze sono abbastanza evidenti. Ma sono visibili anche nelle dinamiche, confrontando i redditi in vari gruppi di paesi e la media europea: il blocco nordico resta ampiamente in vetta con un reddito del 50 per cento più alto di quello della media europea (mentre alla metà degli anni novanta la differenza era solo del 25 per cento); quello occidentale segue a distanza, più alto del 25 per cento; quello del sud, sceso sotto la media europea con la grande crisi del 2008, adesso è il 10 per cento in meno; mentre quello dell’est imbocca una direzione opposta, guadagnando gradualmente terreno ma restando del 35 per cento sotto la media. I paesi ex comunisti entrati nell’Ue hanno registrato, tra il 2000 e il 2017, tassi di crescita annuali medi del 2,9 per cento, mentre nel nucleo originario dell’Europa a 15 il reddito medio pro-capite cresceva, negli stessi periodi, dello 0,4 e dello 0,8 per cento”.
Ma non sono solo gli squilibri tra stati che producono velocità economiche diverse, le tensioni maggiori nascono dentro i confini nazionali ed hanno forti ripercussioni sul processo di unificazione europea. Il caso Brexit è da manuale.
L’Istitute for fiscal studies del Regno Unito ha affidato al premio nobel per l’economia, Angus Deaton, una ricerca sulle diseguaglianze. Un dato fa capire la tendenza: “Nel 2017 lo stipendio medio di un amministratore delegato di un’azienda inserita nel Financial Times stock exchange 100, era 145 volte il salario medio nzionale, mentre nel 1998 era ‘appena’ 47 volte maggiore”.
Le cose non vanno meglio nel Continente al di qua della Manica. Negli ultimi decenni l’1% della popolazione europea più ricca, ha visto crescere il proprio reddito sopra il 3,5% all’anno, mentre la fascia di cittadini inglobata nella povertà cresce del 20%.
Richard Partigton, giornalista del The Guardian, ha chiesto a Branko Milanovic, economista serbo-americano, quali siano gli effetti di tutto ciò nei paesi avanzati. Lo studioso ha risposto con una semplice analogia: “Quando in autostrada il traffico si blocca, gli automobilisti perdono la pazienza se la fila accanto scorre di più, lasciandoli intrappolati. La stessa sensazione sembra aver preso piede tra la maggioranza delle persone, che hanno visto la crescita economica migliorare il tenore di vita solo di pochi fortunati”. Milanovic ha aggiunto: “Il problema non è emerso quando Bill Gates o Jeff Bezos sono diventati straricchi, ma quando i redditi non sono più aumentati in modo corrispondente alle aspettative della popolazione. A quel punto – ha concluso – è emersa la convinzione che qualcuno si stesse accaparrando tutte le ricchezze”.
Come è ormai lampante, assistiamo a una dinamica globale che può avere conseguenze deleterie sull’Unione Europea.
I tentativi di fronteggiare l’esplosione delle diseguaglianze e le conseguenti tensioni sociali e politiche, sono molteplici ma ancora l’UE non sembra aver trovato una direzione di marcia univoca. Tra i suoi provvedimenti si segnalano i piani POR (programmi operativi regionali) finalizzati alla lotta alla disoccupazione, l’impegno per fissare un salario minimo europeo annunciato dall nuova Commissione europea, le direttive in materia di sostegno all’agricoltura. Sono tutti provvedimenti che puntano a incidere su singoli aspetti della frattura sociale apertasi nella popolazione europea.
In questi ultimi mesi si fa più forte la consapevolezza che un approccio puramente economicistico non sia sufficiente rispetto alla complessità del problema. Fin’ora si è operato soprattutto azionando – o cercando di azionare – la leva fiscale. Ma in un’epoca di capitali globali, minacciare tasse più alte può far fuggire gli investitori.
In molti Paesi torna in auge il welfare state, quel sistema di rete sociale pubblica e privata, capace di assicurare sanità, istruzione e pensione a tutti. Dagli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Germania molti esponenti di area politica moderata, stanno rilanciando proposte che guardano allo stato sociale come metodo di inclusione e di riattivazione dell’ascensore sociale oggi bloccato. Economisti come Thomas Piketty ne hanno parlato in libri che sono diventati best seller a livello mondiale, politici come Bernie Sanders negli Stati Uniti e Jeremy Corbyn nel Regno Unito hanno riportato il tema nell’agenda politica, mentre persino il Fondo Monetario Internazionale ha iniziato a parlarne come un problema che non può essere rinviato. A Davos si è molto discusso di tutto ciò.
In Italia, Patrizia Longo dell’Ocse, e Fabrizio Barca economista ed ex ministro del governo Monti, guidano il Forum delle diseguaglianze, un organismo che coordina un centinaio di ricercatori. Nelle scorse settimane hanno reso pubbliche quindici proposte. Sono soluzioni tecniche particolarmente innovative che vanno dallo scambio delle informazioni scientifiche all’interno dell’Ue alle limitazioni da imporre agli algoritmi che gestiscono i nostri dati personali.
di Andrea Lazzeri